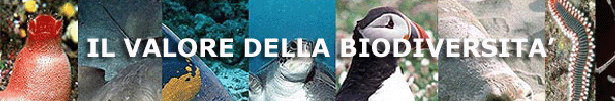La principale minaccia alla biodiversità è oggi rappresentata dall'uomo.
Il tasso naturale di estinzione è stimato in circa una specie all'anno. L'antropizzazione degli ambienti, con la conseguente deforestazione e la pratica agricola delle monoculture determinano un tasso annuale diecimila volte superiore. Ciò vuol dire dire che ogni ora sul pianeta scompaiono 3 specie.
La presenza dell'uomo è causa, direttamente o indirettamente, della scomparsa della biodiversità. Dal 1961 al 1980 sono stati convertiti ad uso agricolo 200 milioni di ettari di foresta e 11 milioni di ettari di prateria, localizzati quasi tutti in Paesi in via di sviluppo e quasi sempre in seguito a pressioni economiche esercitate dai Paesi ricchi.
Le specie viventi che compongono un ecosistema sono strettamente legate in un equilibrio dinamico che orienta il funzionamento dello stesso sistema. Quando una specie scompare, l'equilibrio viene alterato. L'ecosistema riequilibra la perdita di una specie, ma se le specie che vengono a mancare sono tante, l'ecosistema scompare.
La consapevolezza di questo ha portato alla Convenzione sulla Biodiversità che impegna le nazioni che vi hanno aderito a trovare un punto di equilibrio tra produzione di beni ottenuti dalle risorse naturali e conservazione degli ecosistemi. Questo approccio è definito anche "sviluppo sostenibile".
SVILUPPO SOSTENIBILE
Il termine "sviluppo sostenibile" indica una via che permette all'uomo di sviluppare e crescere economicamente, senza al contempo intaccare le capacità rigenerative del pianeta: lo sviluppo di una regione può avere luogo in molti modi, quello più auspicabile è proprio lo sviluppo "sostenibile", basato sul concetto per cui "noi lasciamo il mondo alle future generazioni come l'abbiamo trovato" (sarebbe meglio "migliore di quanto l'abbiamo trovato" ma questo è molto difficile; il concetto è che non dobbiamo lasciare un mondo peggiore).
Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo (che comprende lo sviluppo economico, delle città, delle comunità eccetera) che non compromette la possibilità delle future generazioni di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle risorse naturali (che sono esauribili). L'obiettivo è di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operante quindi in regime di equilibrio ambientale.
Lo sviluppo sostenibile, secondo le Nazioni Unite, è il progresso economico e sociale che comporta il miglioramento della qualità della vita delle persone, nell'ambito della capacità di portata del sistema che sostiene la vita sulla Terra.
Ciò significa far fronte alle esigenze delle attuali generazioni senza compromettere le risorse della Terra e quindi danneggiare le generazioni future.
Il nostro modo di vivere, di consumare, di comportarsi, decide la velocità del degrado entropico (misura dello stato del disordine di un sistema), la velocità con la quale viene dissipata l'energia utile e il periodo di sopravvivenza della specie umana. Si arriva così al concetto di sostenibilità, intesa come l'insieme di relazioni tra le attività umane, la loro dinamica e la biosfera che ha delle dinamiche generalmente più lente. Queste relazioni devono essere tali di permettere alla vita umana di continuare, agli individui di soddisfare le loro necessità e alle diverse culture umane di svilupparsi, ma in modo tale che le variazioni apportate alla natura dalle attività umane stiano entro certi limiti così da non da non distruggere il contesto biofisico globale. Se riusciremo ad arrivare a un'economia da equilibrio sostenibile come indicato da Herman Daly, le future generazioni potranno avere almeno le stesse opportunità che la nostra generazione ha avuto: è un rapporto tra economia ed ecologia, in gran parte ancora da costruire, che passa dalla strada dell'equilibrio sostenibile.
I progetti di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale sono riuniti nell' "Agenda 21", documento di propositi ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo durante la Conferenza su Ambiente e Sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. In Italia l'"Agenda 21" si concretizza dopo la Conferenza di Aaalborg in Danimarca del 1994, dal cui ambito nasce la "Campagna Europea Città Sostenibili". Le numerose amministrazioni che firmarono la Carta di Aaalborg e aderirono alla campagna europea delle città sostenibili stanno promuovendo attualmente processi di Agenda 21 locale sul proprio territorio. Un ulteriore impulso determinante in questa direzione si concretizzò con la nascita del "Coordinamento Nazionale Agende 21 locali", avvenuta nel 1999 a Ferrara, con il proposito di diffondere, valorizzare e monitorare le esperienze di "Agenda 21 locale" attualmente in corso e nel favorire la partnership e lo scambio di informazioni tra gli enti locali. Il Ministero dell'Ambiente con il Bando 2000 ha messo a disposizione delle amministrazioni locali e degli enti parco 12,9 milioni di euro (pari a circa 25 miliardi di lire) e sta sostenendo l'attuazione di 111 progetti. L'ultimo congresso mondiale di sviluppo sostenibile si è tenuto in Sudafrica, a Johannesburg . L'Agenda 21 internazionale è costituita da una piattaforma programmatica di 800 pagine in cui, partendo dai problemi globali che investono la Terra, viene indicato un programma operativo per una transizione verso uno sviluppo sostenibile, includendo obiettivi, responsabilità e stima dei costi.
UN PIANETA SOLO NON BASTA !
Un Pianeta solo non basta. Nel 2050, se consumeremo con il ritmo attuale acqua, suolo fertile, risorse forestali e specie animali, di pianeti infatti ce ne vorranno due.
Sono queste le conclusioni del 'Living Planet Report 2006', l'ultimo rapporto del Wwf, giunto alla sua sesta edizione, che viene lanciato oggi al livello mondiale proprio da uno dei Paesi dallo sviluppo più rapido, la Cina.
Dopo anni di studi gli esperti hanno concluso che quello attuale è un ritmo davvero insostenibile per la Terra, un sistema biologico chiuso. Il Living Planet Report conferma anche una continua perdita di biodiversità, così come analizzato nelle precedenti edizioni.
I grafici degli andamenti delle popolazioni delle specie viventi, spiega il Wwf, dimostrano globalmente una pericolosa discesa: il rapporto dimostra che in 33 anni (dal 1970 al 2003) le popolazioni di vertebrati hanno subito un tracollo di almeno 1/3 e nello stesso tempo l'Impronta ecologica dell'uomo, in altre parole, quanto pesa la domanda di risorse naturali da parte delle attività umane, è aumentata ad un punto tale che la Terra non è più capace di rigenerare ciò che viene consumato.
Gli italiani, come molti altri cittadini del pianeta Terra, divorano più risorse di quante ce ne sono a disposizione e nella classifica mondiale l’Italia si piazza al 29° posto ma, cosa ancor più grave, in coda rispetto al resto dei Paesi europei.
E' evidente, secondo il Wwf, che anche l'Italia ha bisogno di avviarsi rapidamente su una strada di sostenibilità del proprio sviluppo.
Dobbiamo avere bene in mente, perciò, che è, da come impostiamo oggi la costruzione delle nostre città, da come affrontiamo la pianificazione energetica, da come costruiamo le nostre abitazioni, da come tuteliamo e ripristiniamo la biodiversità, che dipenderà il nostro futuro e soprattutto quello dei nostri figli e dei nostri nipoti.
Con un po’ d’aiuto, ma soprattutto, con un pizzico d’attenzione, da parte di tutti noi, si può fare moltissimo.
.
I BIOINDICATORI
Le principali tecniche di biomonitoraggio consistono nell'uso di organismi Bioindicatori (organismi che subiscono variazioni evidenti nella fisiologia, nella morfologia o nella distribuzione spaziale sotto l'influsso delle sostanze presenti nell'ambiente) e Bioaccumulatori (organismi in grado di sopravvivere in presenza di inquinanti che accumulano nei loro tessuti; con il loro uso è possibile ottenere dati sia di tipo qualitativo che quantitativo).
La complessità degli ecosistemi rende complicato e costoso ottenere un quadro completo della qualità ambientale con i sistemi tradizionali (analisi chimico-fisiche).
Usando un opportuno indicatore biologico - come una cellula, una specie, una comunità - si possono monitorare in modo semplice, sintetico ed economico molti parametri ambientali.
Grazie alla capacità di colonizzare un'ampia varietà di ambienti anche con climi diversi, ancora oggi i licheni vengono utilizzati come bioindicatori per l'inquinameto atmosferico.
L'uso di indicatori per monitorare o valuatare le condizioni ambientali è una strategia consolidata in ecologia; è quindi molto importante individuare degli indicatori capaci di indagare la composizione, la struttura e la funzione della biodiversità. Viene definito indicatore di biodiversità ogni taxon per cui le variazioni spaziali del numero di specie siano strettamente correlate con le variazioni spaziali di specie di altri taxa.
Tra i più importanti e comuni indicatori biologici vi sono:
Alghe del genere spirogira e clorella
Artemia salina
Licheni
Organismi planctonici di acque dolci
Microfauna e piccoli artropodi dell'edaphon
I licheni epifiti rappresentano i bioindicatori più utilizzati nella valutazione della qualità dell'aria; questi, pur non essendo capaci di discriminare tra i diversi tipi di inquinanti, sono in grado di stimare la qualità complessiva dell'aria risultando sensibili all'effetto di tutti gli inquinanti contemporaneamente, oltre a quelli derivanti dall'accumulo di sostanze non facilmente rilevabili con i normali mezzi di analisi chimica. L'economicità del loro utilizzo consente di effettuare un numero molto elevato di rilevamenti, coprendo così aree molto ampie, rendendo possibile realizzare affidabili carte tematiche di qualità dell'aria, utili per avere un quadro generale dell'inquinamento.
I licheni possono essere così considerati delle vere e proprie "centraline di rilevamento atmosferico in continuo".
I licheni sono ottimi bioindicatori dell’inquinamento dell’aria poiché hanno delle peculiari caratteristiche fisiologiche ed ecologiche:
- non hanno un apparato radicale e per il loro metabolismo dipendono quasi esclusivamente dalle deposizioni secche ed umide dell’atmosfera;
- non hanno né cuticola, né stomi, per cui l’assorbimento di eventuali contaminanti atmosferici, sia in forma gassosa, che in soluzione o associati al particellato, avviene su tutta la superficie;
- sono fotosinteticamente attivi solo allo stato idratato e posseggono meccanismi di idratazione che dipendono in massima parte dal tasso di umidità atmosferica;
- sono presenti quasi ovunque;
- hanno un metabolismo molto lento e quindi il loro ciclo vitale è molto lungo;
I licheni possono essere utilizzati per il biomonitoraggio secondo due strategie principali:
come bioindicatori e come bioaccumulatori. Nel primo caso si sfrutta la loro sensibilità agli inquinanti atmosferici per ottenere una stima della qualità dell’aria dell’area indagata . Nel secondo caso vengono ricercate le specie in grado di accumulare alte concentrazioni di contaminanti atmosferici, in genere metalli pesanti e radionuclidi. I due metodi possono essere considerati come complementari, in quanto permettono di ottenere informazioni su diversi tipi di inquinanti.
Esistono varie tecniche di monitoraggio dell’inquinamento tramite licheni, tra cui l’ Index of Atmospheric Purity (I.A.P.), metodo standardizzato da Ammann (1987) ed applicato in Italia da Nimis (1990), che permette una valutazione numerica quantitativa del grado di inquinamento atmosferico attraverso la frequenza dei licheni epifiti riscontrati in un apposito reticolo di campionamento. Le mappe della qualità dell’aria vengono ottenute attraverso l’uso di specifici programmi di cartografia computerizzata che trasformano i singoli dati in un modello distribuzionale continuo.
I BIOACCUMULATORI
I bioaccumulatori sono particolari organismi dotati della capacità di assorbire dall'ambiente determinate sostanze per poi trattenerle all'interno dei propri tessuti senza eliminarle tramice processi metabolici. Proprio per le modalità di utilizzo si selezionano per questo scopo piante e animali estremamente resistenti agli inquinanti.
L'utilità principale di questo tipo di organismi è quella di bioindicatori: monitorando costantemente le colture di bioaccumulatori è possibile valutare lo stato di salute dell'ecositema, analizzando fattori come la presenza di metalli pesanti piombo, vanadio. cadmio, cromo, zinco, nichel, manganese) , sostanze chimiche, idrocarburi o elementi radioattivi (radionuclidi come il cesio 137).
Diversi tipi di pianta possono essere utilizzati come bioaccumulatori. I più comuni tipi di vegetazione usata a tale scopo sono i licheni e i muschi, ma ci sono anche diversi tipi di coleotteri terrestri e microorganismi acquatici che si prestano allo scopo.
Misurando tramite spettrofotometria le percentuali di inquinanti contenute nelle strutture cellulari di alcune colture di licheni (Xantoria parietina, Pseudevernia furfuracea e Licheni Multiflorum) sviluppatasi su alberi a corteccia acida posti in prossimità delle centrali elettriche e comparandole con i valori di una coltura mantenuta in ambiente protetto è possibile ad esempio misurare la presenza di SO2 e NOx nell'atmosfera. È possibile effettuare misurazioni differenziali tramite la comparazione tra le analisi dei talli di età differenti.
Il rilevamento avviene su diversi alberi contemporaneamente, suddividendo la coltura in zone tramite un reticolo, per ridurre gli errori dovuti alle normali deviazioni statistiche tipiche delle misure scientifiche e alle influenze esterne dell'ambiente, come i fenomeni di dilavamento da pioggia.
In condizioni particolari è possibile utilizzare come bioaccumulatore anche le foglie di alberi molto diffusi, spesso tigli, prelevando le foglie a campione dalle colture circostanti l'area interessata.
A seconda del tipo di bioaccumulatore (licheni, foglie, erbe in vaso, muschi) cambia il tempo necessario all'esposizione, da poche settimane per i muschi a diversi anni per i licheni.
L'utilizzo di bioaccumulatori e bioindicatori è un metodo efficace e significativo per valutare la presenza di anomalie dell'equilibrio biologico di aree interessate dall'attività umana, anche se non permette di distinguere facilmente tra i risultati dovuti all'attività antropica e quelli invece dovuti a cause naturali.
L'accumulo di materiali nocivi viene classificato con una scala da 1 a 7, basata sulla deviazione dei dati rilevati con quelli previsti e misurati in condizioni di non-alterazione.
Molti talli lichenici assorbono e accumulano diverse sostanze inquinanti: radionuclidi, zolfo, fluoro, idrocarburi clorurati, metalli, nonchè particelle, polveri e fumi in sospensione nell'aria, la cui presenza è dovuta principalmente agli scarichi urbani o alla combustione di petrolio e di carbone.
I licheni possono così essere utilizzati anche nelle indagini sulla presenza di determinati contaminanti.
Molti organismi marini, in particolare i pesci, accumulano sostanze tossiche (cadmio, mercurio, arsenico).
Il pesce spada è un predatore e accumula nei tessiti grassi una gran quantità di sostanze tossiche (liposolubili). Tutti i predatori che si trovano alla sommità della piramide alimentare (anche l'uomo) risentono dell'accumularsi e del concentrarsi degli inquinanti nel cibo.
Un inquinante che è molto diluito nell'acqua, si concentra un poco nelle alghe, di più nei microorganismi che si nutrono di alghe, ancora di più nei pesciolini che si mangiano quei microorganismi e raggiunge il massimo nei pesci predatori, come, appunto, il pesce spada.
La contaminazione dell'ambiente marino, in modo particolare quella da metalli pesanti, costituisce uno dei maggiori problemi di tossicologia ambientale. Alcuni elementi, infatti, a causa delle loro caratteristiche, possono ritrovarsi a concentrazioni tossiche negli organismi marini. La qualità igienico-sanitaria dei prodotti della pesca desta preoccupazione per quei metalli e per quelle specie particolarmente soggetti ai fenomeni della biomagnificazione lungo la catena trofica o della bioconcentrazione attraverso le acque (Thibaud, 1992; Orlando, 1989). Oltre al piombo, conosciuto per la sua tossicità da tempo immemorabile, altri elementi assumono particolare interesse: il mercurio, oggetto da qualche decennio di interesse legislativo-ispettivo, il cadmio e l'arsenico, più recentemente indagati per la potenziale pericolosità dei livelli ambientali e per la loro incidenza sulla dieta (Burgat-Sacaze, 1996; Campanini, 1998).
LA BIOMAGNIFICAZIONE
La magnificazione biologica, o biomagnificazione, è un fenomeno di accumulo di sostanze nocive lungo una catena alimentare. Quanto più lunga è la catena alimentare tanto è più alta la concentrazione, al vertice della catena, di sostanze nocive.
Quando una sostanza entra nella catena alimentare, ad esempio da un produttore primario o da un consumatore primario, ha una bassa concentrazione. Ad ogni anello della catena la concentrazione della sostanza aumenta e, per essere più precisi, tende ad accumularsi in determinate zone dell' animale. Molti POP (persistent organic polluttants, ovvero inquinanti organici persistenti) sono liposolubili e per questo motivo si riscontrano nel tessuto adiposo degli animali mentre altri inquinanti, come ad esempio il mercurio ed i suoi derivati, preferiscono il tessuto sanguigno e per questo motivo tendono ad accumularsi nel fegato.
Per misurare se in una catena alimentare vi è o meno biomagnificazione si usa l'indice TTC ovvero Trophic Transfer Coefficient (coefficiente di trasfermiento trofico) che è il rapporto tra la concentrazione della sostanza della preda e la concentrazione della sostanza nel suo diretto predatore. Se tale rapporto è minore ad 1 allora non vi è biomagnificazione viceversa, se il rapporto è maggiore di 1, esiste una correlazione di biomagnificazione.
Non tutti gli inquinanti possiedono i “requisiti” per dare luogo al fenomeno dell’amplificazione biologica. Infatti, devono essere composti con un periodo di vita medio-lungo (altrimenti vengono degradati prima di passare al livello successivo della catena alimentare); devono essere composti solubili nei lipidi e non nell’acqua (altrimenti possono essere eliminati con le urine e non si accumulano nei tessuti: ecco perché per verificare il bioaccumulo si effettuano controlli sui tessuti adiposi degli organismi o sul latte delle femmine di mammifero, ricco di lipidi); inoltre, devono essere biologicamente attivi (altrimenti, l’accumulo nei tessuti non è nocivo).
Esempi classici di biomagnificazione sono quelli del metilmercurio e del DDT. Molto diffuso nel Mar Mediterraneo il mercurio proveniente attraverso i fiumi dagli scarichi industriali e il metano dai giacimenti di gas naturale.
Per effetto della biomagnificazione diviene potenzialmente pericoloso mangiare pesci di grossa taglia come tonni, pesci spada e squali, in quanto occupando i piani alti della piramide alimentare accumulano grandi quantità di metilmercurio, sostanza molto tossica.
Un caso molto studiato di amplificazione biologica, e anche il primo, è quello relativo al DDT, insetticida largamente impiegato in agricoltura fino agli anni Sessanta del XX secolo e messo al bando nel 1972 da gran parte dei paesi industrializzati. Si calcola che se la concentrazione di DDT nel primo livello di una catena alimentare acquatica (fitoplancton) è di 0,000003 ppm (parti per milione), passando al secondo livello (zooplancton) la concentrazione sale a 0,04 ppm; nel terzo livello, costituito da pesci di piccola dimensione, diventa 0,5 ppm; salendo ulteriormente, nei pesci predatori che si nutrono dei pesci più piccoli il valore del DDT è pari a 2 ppm; infine, nel superpredatore al vertice della catena alimentare, un’aquila dalla testa bianca, la concentrazione raggiunge 25 ppm.
Il bioaccumulo del DDT fu dimostrato dalla zoologa statunitense Rachel Carson, la cui opera Primavera silenziosa (Silent Spring) del 1962 diede notevole risonanza alla pericolosità dei pesticidi chimici. Sono state compiute molte ricerche anche sul bioaccumulo di piombo, cromo, zinco, mercurio e diossina.
In generale correlati con questo fenomeno sono molti metalli pesanti, i composti organo-alogenati e i radionuclidi, sostanze per lo più cancerogene, che permangono nelle acque o nel terreno senza subire degradazione. Tali sostanze possono essere ingerite dai livelli più bassi della rete trofica, ad esempio da un insetto, dove permangono all'interno di tessuti e cellule; a sua volta questo organismo sarà preda del livello superiore della catena alimentare, per esempio un pesce o un uccello, dove tali sostanze tossiche verranno ulteriormente a concentrarsi. Il processo prosegue lungo tutta la rete fino ai grandi predatori, uomo compreso, dove le concentrazioni saranno tali da avere effetti anche letali a livello individuale.
|