La causa principale della allarmante alterazione della diversità biologica della Terra è l'influenza dell'uomo sull'ecosistema terrestre a livello globale. L'uomo ha alterato profondamente l'ambiente trasformando il territorio, modificando i cicli biogeochimici globali, sfruttando direttamente molte specie tramite la caccia e la pesca e aumentando la possibilità di trasferimento degli organismi viventi da una zona all'altra del pianeta. Tra le più importanti cause di estinzione o minaccia sono la distruzione dell'habitat, l'introduzione di specie esotiche e il prelievo venatorio. In particolare, la perdita di habitat è di gran lunga il maggior pericolo per le specie a rischio di estinzione. Un dato non confortante riguarda l'ignoranza dei fattori che hanno portato all'estinzione di più di un terzo delle specie di avifauna scomparse finora. Anche uno studio condotto su gran parte delle specie minacciate negli Stati Uniti ha individuato nella degradazione e nella distruzione degli habitat le principali minacce alla biodiversità, seguite dalla competizione e dalla predazione con specie non autoctone. Grande importanza assume anche l'inquinamento. Le attività umane hanno, infatti, alterato profondamente i cicli biogeochimici fondamentali al funzionamento globale dell'ecosistema. Il progresso (umano) ha anche altri effetti sull’ambiente. Primo fra tutti l’inquinamento. Un problema non semplice da prevenire, ancor meno da curare. Molti inquinanti non sono facilmente e rapidamente rilevabili né tanto meno estirpabili. L’inquinamento, poi, non rispetta i confini di nazioni o di interi continenti. Una volta nell’aria o nell’acqua si diffonde a chilometri di distanza e rappresenta, quindi, un problema che andrebbe affrontato a livello internazionale. Come nel caso del riscaldamento globale, il cui impatto è potenzialmente devastante per molti habitat e specie tra quelli ospitati dal nostro pianeta. Se non riusciremo a limitare l’emissione dei gas responsabili dell’effetto serra – prima fra tutte l’anidride carbonica –, alla fine del secolo la temperatura media terrestre potrebbe aumentare anche di tre-quattro gradi e il livello dei mari di diverse decine di centimetri (la Terra non ha mai sperimentato, almeno in epoca storica, cambiamenti climatici così repentini). Con effetti sulla biodiversità facilmente intuibili, soprattutto se si pensa agli ecosistemi costieri e a quelli montani Fonti d'inquinamento sono, oltre alle industrie e gli scarichi civili, anche le attività agricole che impiegando insetticidi, pesticidi e diserbanti alterano profondamente i suoli. A questo proposito va ricordato il fenomeno della biomagnificazione, che consiste nell'amplificazione della concentrazione di sostanze tossiche all'interno delle reti trofiche dai livelli più bassi a quelli più elevati. Conseguenza di questo processo è l'accumulo di notevoli quantità di sostanze chimiche nocive (in particolare metalli pesanti) negli organismi che si trovano in cima alla catena trofica (rapaci, grandi carnivori).
Una delle principali minacce per la sopravvivenza di molte specie è l'alterazione, la perdita e la frammentazione dei loro habitat causata dai profondi cambiamenti del territorio condotti ad opera dell'uomo in conseguenza dell'esplosione demografica, dello sviluppo industriale, dell'estensione della rete dei trasporti e dell'industrializzazione dell'agricoltura. Nell'ultimo secolo i maggiori cambiamenti dell'uso del suolo hanno riguardato l'aumento delle superfici per l'agricoltura e per l'allevamento, lo sviluppo delle aree urbane e commerciali, il massiccio disboscamento, l'ampliamento delle reti stradali e delle relative infrastrutture, la costruzione di impianti idroelettrici, lo sviluppo della rete idrica e delle opere idrauliche, la cementificazione dell'alveo dei fiumi, lo sfruttamento dei giacimenti del sottosuolo, la costruzione di infrastrutture per le attività ricreative e sportive
In seguito a queste trasformazioni, gli ambienti naturali vengono distrutti, alterati e parcellizzati, causando la perdita e la frammentazione degli habitat. Se il concetto di perdita di habitat risulta intuitivo, il fenomeno della frammentazione va invece approfondito. Con questo termine si indica il processo di parcellizzazione di un territorio in sottoaree tra loro parzialmente connesse o totalmente isolate, così che gli habitat adatti ad una specie risultano distribuiti sul territorio a "macchia di leopardo''. La frammentazione è dovuta sia alla perdita di habitat originari che alla costruzione di barriere (quali strade, linee elettriche, canali artificiali e impianti sciistici) che impediscono il libero movimento degli animali all'interno del territorio.
Nello studio del fenomeno della frammentazione è utile introdurre il concetto di patch (termine inglese che vuol dire ``chiazza''), con il quale si intende un'area che presenta condizioni ambientali omogenee. La frammentazione, quindi, ha l'effetto di ridurre le dimensione dei patches e aumentare la distanza, e quindi l'isolamento, tra patches simili. Questo processo può anche modificare la qualità degli habitat rimasti e aumentare il disturbo causato da attività antropiche. Patches di ambienti naturali di per sé non alterati ma circondati da paesaggi modificati dall'uomo possono risultare non più adatti per certe specie.
La conseguenza principale della frammentazione degli habitat naturali è la suddivisione della popolazione originariamente distribuita su tutto il territorio in sottopopolazioni in scarso contatto fra loro, ciascuna occupante un solo patch o pochi patches vicini. Queste sottopopolazioni sono ovviamente meno consistenti di quella originale e risultano, quindi, più vulnerabili alle fluttuazioni climatiche naturali, ai fattori di disturbo antropico, a possibili epidemie e al deterioramento genetico dovuto a inincrocio. Inoltre, in ambiente frammentato, l'habitat di una specie risulta maggiormente a contatto con habitat di altre specie e questo provoca l'aumento dei tassi di predazione, di competizione, di parassitismo. In sostanza ciascuna di queste sottopopolazioni è sottoposta ad un maggior rischio di estinzione e l'assenza di contatto tra i vari patches impedisce o rallenta la ricolonizzazione di un area in cui la popolazione si sia estinta. La specie corre perciò il rischio di sparire da un numero sempre maggiore di patches finché le probabilità di ricolonizzazione diventano praticamente nulle e la specie si può considerare estinta su tutto il territorio.
Un territorio frammentato risulta per certi aspetti simile a un arcipelago: i patches adatti ad una certa specie sono simili a isole e l'ambiente circostante, meno ospitale, è simile all'Oceano. Come ha acutamente notato Levins (1970), le cime delle montagne, i tronchi caduti, le chiazze di vegetazione o, meno intuitivamente, le regioni di temperatura o umidità ottimale per una specie, sono tutte isole per gli organismi appropriati. In tali frammenti valgono allora le considerazioni che si sono fatte in precedenza per le isole: dato l'esiguo numero di individui che compongono le popolazioni locali, è facile che si inneschino dei meccanismi di tipo effetto Allee, che vi sia inbreeding e che sia elevata la probabilità di estinzione della popolazione locale a causa di eventi sfavorevoli del tutto casuali (stocasticità demografica). Nello studio della frammentazione, come confermato da vari studi sul campo, può quindi essere utile ricorrere alla teoria della biogeografia delle isole. In particolare, patches con aree minori sono in grado di ospitare un minor numero di specie (effetto area). Questo comporta che la diminuzione delle dimensioni di un patch per perdita, alterazione o frammentazione di habitat ha come inevitabile conseguenza l'estinzione delle specie che necessitano di spazi vitali maggiori alla dimensione del patch e, quindi, la diminuzione del numero di specie in esso presenti. Anche l'effetto distanza riveste una notevole importanza in ambiente frammentato. Il tasso di colonizzazione di un patch risulta, infatti, dipendere dalla sua distanza dagli altri patches e, quindi, un patch più isolato ha più difficoltà ad essere raggiunto e ricolonizzato.
La riduzione e la frammentazione degli habitat possono innescare anche fenomeni di “effetto barriera” che ostacola gli spostamenti della fauna, deriva genetica e conseguente scarsa capacità adattativa a variazioni ambientali, controbilanciata dal flusso genico, importante fattore omogeneizzante delle popolazioni. Conoscere il rapporto tra queste due forze è la base per la formulazione di appropriate strategie di conservazione.
Un'ulteriore causa di minaccia per molte specie è costituita da un eccessivo prelievo ittico e venatorio. Tale prelievo può costituire la causa prima oppure aggravare situazioni già a rischio per la degradazione degli habitat. Le specie più minacciate dalla caccia e dalla pesca sono, oltre quelle la cui carne è commestibile (tipicamente la selvaggina e gli stock ittici), anche quelle la cui pelle e le cui corna, tessuti e organi hanno un alto valore commerciale (come l'elefante dalle cui zanne si ricava l'avorio o il rinoceronte al cui corno vengono attribuite inesistenti proprietà afrodisiache). La caccia e la pesca non compromettono sempre la diversità di un ecosistema ma divengono seria minaccia di estinzione di una specie quando la sfruttano eccessivamente, cioè quando il tasso di prelievo è maggiore del tasso di rinnovamento della specie. ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Un fattore, spesso trascurato, di declino e di estinzione di molte specie è l'introduzione in un territorio di specie alloctone, cioè di specie che sono originarie di altre aree geografiche e che, quindi, non si sono adattate, attraverso il processo di selezione naturale, all'ambiente nel quale vengono immesse. È importante tenere presente che le specie non solo si sono evolute nel corso di milioni di anni, ma si sono coevolute, ovvero si sono adattate reciprocamente in maniera da coesistere all'interno di determinati territori caratterizzati da specifiche condizioni fisiche, chimiche, climatiche, vegetazionali. L'introduzione di specie alloctone rappresenta sempre un pericolo. È stato valutato che circa il 20% dei casi di estinzione di uccelli e mammiferi è da attribuirsi all'azione diretta di animali introdotti (soprattutto mammiferi). Ciò può essere dovuto a diverse cause: alla competizione per risorse limitate, alla predazione da parte della specie introdotta e alla diffusione di nuove malattie e parassitosi. Inoltre non bisogna trascurare i danni che molte specie introdotte possono arrecare alla vegetazione naturale, alle coltivazioni e alla zootecnia. Purtroppo in Europa il problema delle introduzioni di specie alloctone è stato trattato in passato con molta superficialità. Due casi sono emblematici: quello della vongola verace orientale, o vongola filippina (Tapes philippinarum), che ha portato in molte zone alla scomparsa della specie autoctona (Tapes decussatus), e quello dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis), di importazione nordamericana, che sta soppiantando lo scoiattolo rosso europeo (Sciurus vulgaris).
Un ulteriore problema per la conservazione della biodiversità è rappresentato dall'introduzione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Un organismo geneticamente modificato (OGM) o transgenico è un organismo nel cui corredo cromosomico è stato introdotto, tramite le tecniche dell'ingegneria genetica, un gene estraneo prelevato da un organismo donatore appartenente a diversa specie vivente, anche molto distante dal punto di vista della classificazione tassonomica dalla specie "ospite". Per tale via si conferisce all'organismo la caratteristica desiderata, come ad esempio nel caso dei vegetali, la resistenza agli erbicidi o a determinati insetti nocivi. ( http://www.gm-info.gov.uk/)
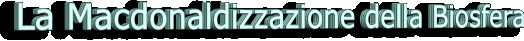
In tutto il mondo si diffondono le stesse specie
di piante e animali. E si riduce così la biodiversità
creata dagli agricoltori in 12 mila anni di storia.
Qualche studioso l'ha definita "MacDonaldizzazione" della biosfera. Si tratta della forma meno nota di globalizzazione: quella delle specie biologiche. Animali e piante, cioé, che vengono trasferiti, sia casualmente, sia intenzionalmente, per fini commerciali o sportivi, in un habitat in cui non erano originari. E che spesso, prendono il sopravvento sulle specie autoctone invadendo l'ambiente.
In tutto il mondo si stanno diffondendo piante e animali identici, proprio come in tutte le città spuntano i fast food che offrono ovunque lo stesso menu. I panini e le bibite del mondo naturale si chiamano lantana e robinia (un arbusto e un albero entrambi d’origine americana), ratto e passero. Partono dalle aree più antropizzate e cioè legate alle attività umane, poi invadono tutti gli ecosistemi, diventano gli organismi dominanti e in poco tempo riducono a zero la biodiversità.
La causa? L’omogeneizzazione dell’agricoltura. La McDonaldizzazione, infatti, parte dai campi e dalle stalle. In Bangladesh e negli Stati Uniti, si coltivano varietà identiche di mais e soia e si allevano ceppi genetici standardizzati di mucche frisone e maiali siluro.
Si tratta di vegetali e animali che sono stati messi a punto dalle grandi compagnie internazionali e assicurano raccolti e rese decisamente superiori a quelli delle varietà tradizionali, che vengono quindi abbandonate. Così però si perde la biodiversità agricola, vale a dire le migliaia di piante coltivate e razze animali che i contadini di tutto il mondo hanno da sempre utilizzato.
Infine, altri fattori di rischio per la biodiversità sono
la trasformazione del territorio per l’abbandono delle pratiche tradizionali, lo spopolamento delle montagne e la realizzazione di grandi opere ad alto impatto sulla biodiversità e sul paesaggio.
 Le minacce principali alla biodiversità di ambienti acquatici possono, inoltre, derivare dal sovrasfruttamento, dall'alterazione chimico-fisica, dall'inquinamento e dall'introduzione di specie aliene. Nelle tecniche di biomonitoraggio della qualità dell'acqua vi sono:
test di tossicità per misurazioni sulle risposte biomolecolari e fisiologiche di organismi nei confronti di tossici in situazioni sperimentali, compresi biosaggi e sistemi di controllo (tossicità acuta, tossicità cronica, genotossicità, bioaccumulazione e biomagnificazione);
monitoraggio degli ecosistemi per misure sull'integrità di ecosistemi sottoposti a perturbazioni ambientali. Tutti i metodi di monitoraggio per la valutazione della struttura di un ecosistema si traducono in campionamenti di specifici gruppi di biota. Avremo indici per specie indicatrici, indici di ricchezza, indici di abbondanza, indici di diversità, indici biotici.
All Rights Reserved. Text and images on this website may not be redistributed or put
|



